Il Metodo LBT© si propone di migliorare la vita delle persone attraverso l’integrazione di tecnologie all’avanguardia nei settori dell’educazione, dello sport, delle aziende, delle sfide sociali e della terza età. Fondato sul concetto di plasticità cerebrale, che si riferisce alla capacità del sistema nervoso di cambiare la sua struttura e il suo funzionamento in risposta alla diversità dell’ambiente, il Metodo LBT© mira non solo a migliorare le capacità cognitive, ma anche a promuovere il benessere emotivo e fisico. Questo metodo si propone di migliorare o mantenere le attività cognitive e motorie e, allo stesso tempo, attivare un approccio non farmacologico. Attraverso l’utilizzo di tecnologie innovative, il Metodo LBT© aspira a costruire un mondo in cui l’accesso a tali risorse sia equo e inclusivo, consentendo a ogni individuo di sviluppare pienamente il proprio potenziale cognitivo, emotivo e fisico, e di vivere una vita più soddisfacente e significativa.
Il Metodo LBT© si articola attraverso i seguenti passaggi:
Il Metodo LBT© si avvale di algoritmi avanzati per garantire la personalizzazione e l’efficacia dei percorsi formativi. Questi algoritmi rappresentano il cuore tecnologico del metodo, permettendo di adattare i contenuti e monitorare il progresso degli utenti in modo dinamico e continuo. Di seguito, si approfondiscono le caratteristiche e i funzionamenti principali degli algoritmi di personalizzazione e di monitoraggio.
Algoritmo di Personalizzazione
L’algoritmo di personalizzazione del Metodo LBT© è progettato per adattare i contenuti formativi alle esigenze specifiche di ciascun utente. Questo processo di adattamento è basato sui risultati dei test iniziali e sul progresso continuo dell’utente. L’algoritmo analizza i dati raccolti per generare un percorso formativo su misura.
Funzionamento:
Evidenze Scientifiche: Studi recenti hanno dimostrato che l’uso di algoritmi di personalizzazione può migliorare significativamente i risultati dell’apprendimento (Dede, 2014; Woolf, 2010). Questi algoritmi sono in grado di adattare i contenuti formativi in modo più efficace rispetto ai metodi tradizionali, aumentando l’engagement e la motivazione degli utenti.
Algoritmo di Monitoraggio
L’algoritmo di monitoraggio è progettato per analizzare i dati di apprendimento degli utenti in tempo reale e fornire feedback continuo. Questo algoritmo utilizza tecniche di analisi dei dati per tracciare il progresso degli utenti e suggerire modifiche ai percorsi formativi per ottimizzare i risultati.
Funzionamento:
Evidenze Scientifiche: La letteratura scientifica ha evidenziato che il monitoraggio continuo e il feedback personalizzato sono essenziali per migliorare l’efficacia dei programmi di apprendimento (Shute, 2008). L’uso di algoritmi avanzati per l’analisi dei dati di apprendimento consente di fornire feedback più precisi e tempestivi, migliorando l’engagement e le performance degli utenti (Smith et al., 2018).
Gli algoritmi di personalizzazione e di monitoraggio utilizzati nel Metodo LBT© rappresentano strumenti potenti per ottimizzare i percorsi formativi e massimizzare i risultati dell’apprendimento. Grazie all’integrazione di tecniche avanzate di analisi dei dati, questi algoritmi consentono di offrire un’esperienza di apprendimento altamente personalizzata e adattiva, promuovendo sia lo sviluppo cognitivo che il benessere emotivo e fisico degli utenti.
Il Metodo LBT© si avvale delle seguenti tecnologie:
L’idea parte da un concetto di fondo: la plasticità celebrale: la plasticità cerebrale si riferisce alla capacità del sistema nervoso di cambiare la sua struttura e il funzionamento per tutta la vita, come reazione alla diversità dell’ambiente. (Kolb, B., Mohamed, A., & Gibb., 2010)
Nel corso degli ultimi anni, l’indagine scientifica sulle funzioni cognitive e il loro miglioramento mediante l’applicazione di training cerebrale ha acquisito un’eccezionale rilevanza. Questo interesse si estende ben oltre l’ambito clinico, pervadendo diverse aree di ricerca e applicazione. Il training cerebrale è impiegato con intento riabilitativo in casi di deficit cognitivi, spesso associati a disturbi neurodegenerativi o psichiatrici, che compromettono le capacità cognitive (Hallock et al., 2016; Motter et al., 2016). Inoltre, tale pratica è utilizzata per l’incremento delle funzioni cognitive in contesti specifici, quali l’ambiente sportivo, educativo e aziendale, mirando al potenziamento delle prestazioni cognitive e del benessere complessivo degli individui (Walton et al., 2018).
Le funzioni cognitive sono processi mentali che facilitano l’elaborazione degli input provenienti dall’ambiente esterno, permettendo così la generazione di risposte comportamentali adeguate a tali stimoli (Revlin, 2014). Esse si suddividono in due categorie principali: le funzioni cognitive di base e quelle complesse.
All’interno delle funzioni cognitive di base, è fondamentale menzionare i processi attentivi. L’attenzione è una capacità che consente di focalizzare le risorse cognitive su specifici input ambientali. Robertson e Manly (1999) hanno classificato i processi attentivi in diverse categorie. Tra queste, l’attenzione sostenuta o vigilanza, che si riferisce alla capacità di direzionare volontariamente l’attenzione per un periodo esteso sugli elementi dell’ambiente. Inoltre, esiste l’attenzione selettiva, che implica la capacità di concentrarsi su determinati input, trascurando altri. Infine, l’attenzione divisa permette di indirizzare l’attenzione simultaneamente su più stimoli.
Le funzioni esecutive, che costituiscono le funzioni cognitive complesse, possono essere descritte come insiemi di processi cognitivi finalizzati alla pianificazione e all’organizzazione dei comportamenti e delle emozioni di un individuo, soprattutto in contesti nuovi o particolarmente impegnativi, che richiedono l’impiego di strategie adattive (Owen, 1997). Le funzioni esecutive sono cruciali in tutte quelle situazioni in cui l’individuo è chiamato a svolgere azioni mirate. Esse facilitano il riconoscimento e la memorizzazione degli stimoli rilevanti, l’elaborazione di un piano d’azione, la selezione di comportamenti adeguati per affrontare tali stimoli e, infine, il monitoraggio dei risultati (feedback) per, se necessario, apportare modifiche alle decisioni future.
Le funzioni esecutive sono quelle abilità che stanno alla base delle strategie di risoluzione dei problemi e, secondo il modello teorico di Miyake et al. (2000), possono essere categorizzate in tre principali componenti:
L’interazione delle tre funzioni esecutive definisce un’ulteriore categoria di funzioni di ordine superiore (Lunt et al., 2012):
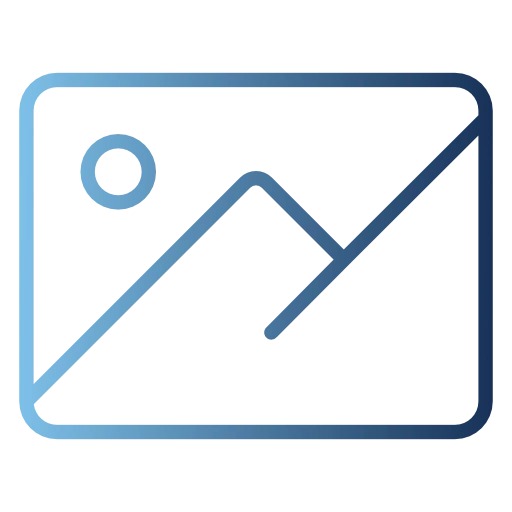
Meccanismo di memoria che ci permette di trattenere nella mente una quantità limitata di informazioni (7 ± 2 elementi) durante un breve periodo di tempo stimato in diversi secondi. Un danno in questa abilità cognitiva può ostacolare l’acquisizione di nuovi ricordi.

Componente della memoria sensoriale che si occupa di elaborare degli stimoli sonori che riceviamo dall’ambiente e di trattenere le informazioni fonologiche durante un breve periodo di tempo.
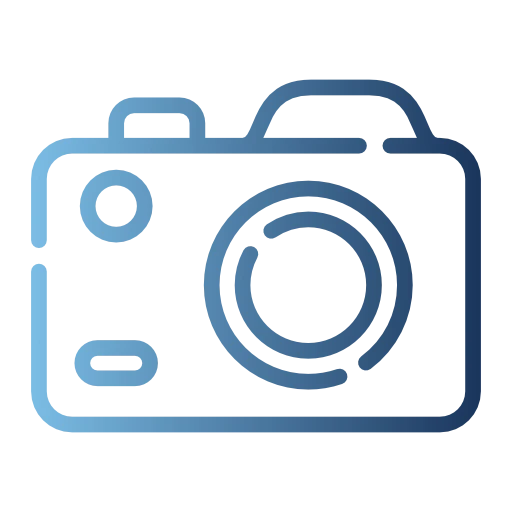
Capacità di trattenere una piccola quantità di informazioni visive (lettere o parole scritte, informazioni verbali, simboli o figure, colori…)
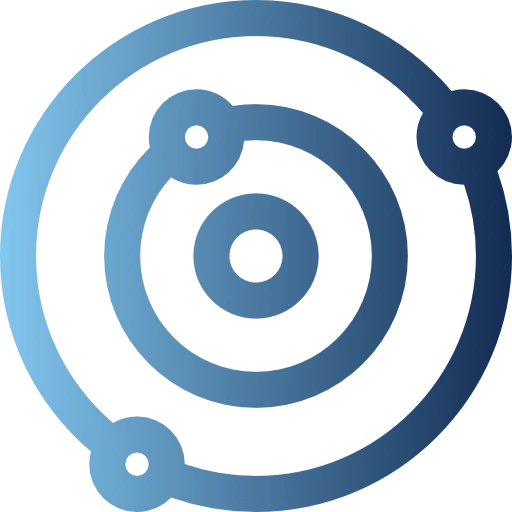
Capacità di far riferimento ad un oggetto, persona, luogo, concetto o entità chiamandolo per il proprio nome. L’abilità di trovare nel nostro “magazzino lessicale” la parola concreta che stiamo cercando e riprodurla.
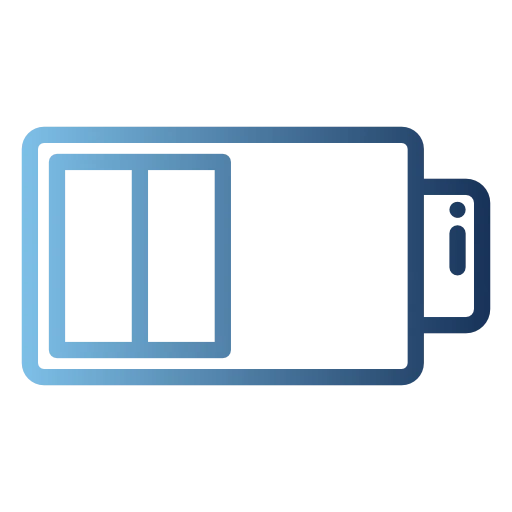
Insieme di processi che ci permettono l’immagazzinamento e l’uso temporale delle informazioni per realizzare attività cognitive complesse come la comprensione del linguaggio, la lettura, le abilità matematiche, l’apprendimento e il ragionamento
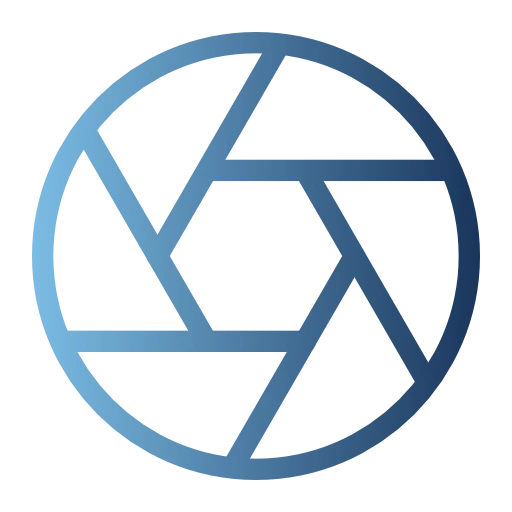
Capacità di decodificare, immagazzinare e recuperare ricordi il cui contenuto no siano parole, per esempio; volti, figure ed immagini, melodie, suoni e rumori, simboli scritti, ecc…
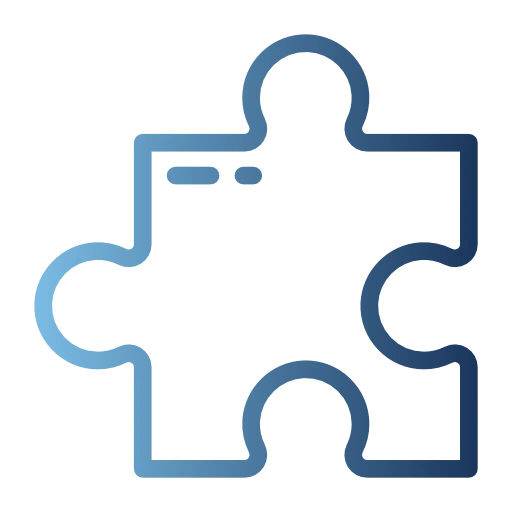
Capacità di memorizzare e discriminare la fonte reale di una specifica memoria. Questo tipo di memoria ci permette di ricordare i diversi aspetti che hanno accompagnato l’apprendimento di un evento (organizzazione temporanea delle sequenze, fonte delle informazioni, ecc….).
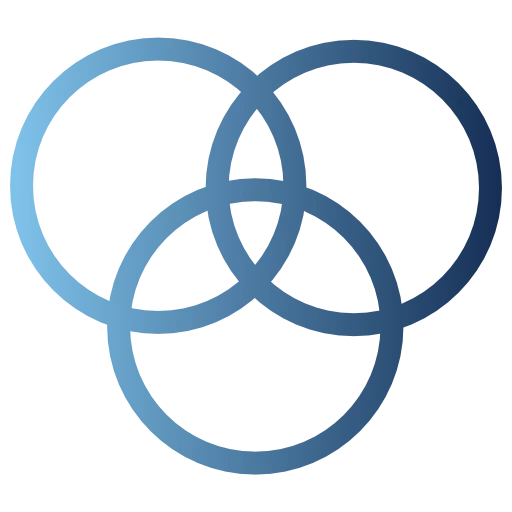
Capacità di interpretare correttamente le informazioni che percepiscono i nostri occhi (fotorecezione, trasmissione e trattamento di base, elaborazione e percezione delle informazioni).
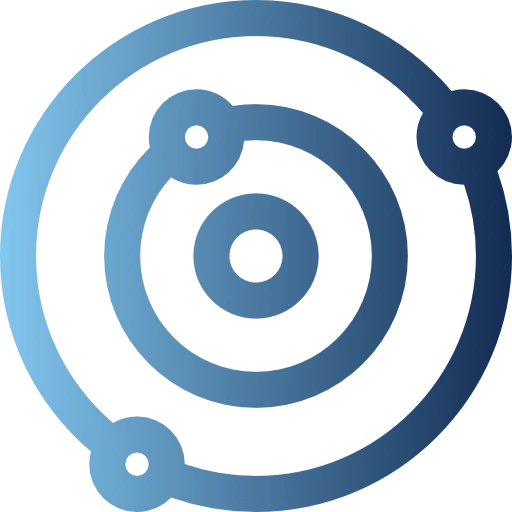
Capacità dell’essere umano di essere cosciente della sua relazione con l’ambiente circostante (sensibilità esterocettiva) e con se stesso (sensibilità enterocettiva). Permette di comprendere la disposizione dell’ambiente e il nostro rapporto con esso.
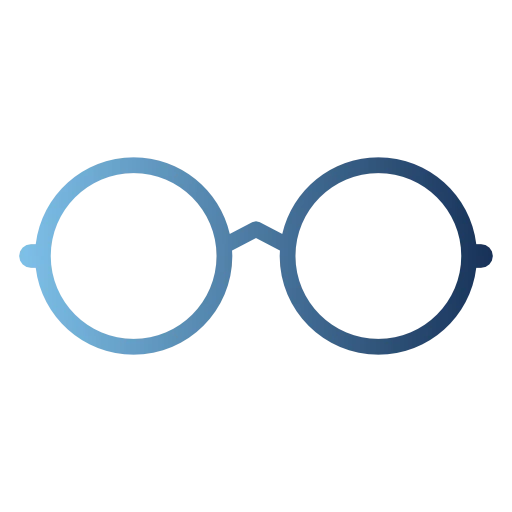
Capacità di cercare attivamente le informazioni rilevanti nell’ambiente che ci circonda, in modo rapido ed efficiente. Questa funzione della percezione visiva è diretta dall’attenzione e ci permette di rilevare e riconoscere stimoli visivi.
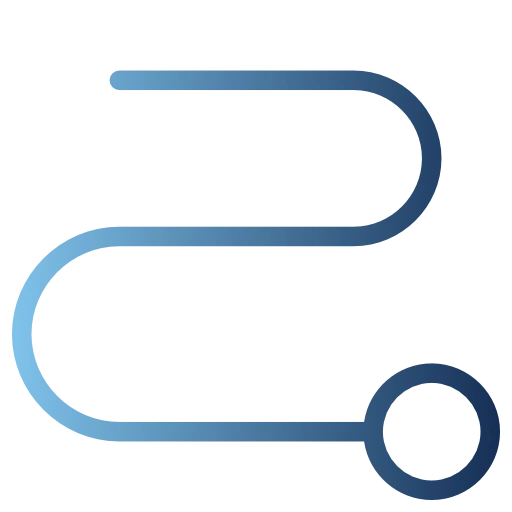
Elaborazione mentale che ci consente di prevedere o generare una risposta quando non abbiamo la soluzione disponibile. Questa capacità ci permette di prevedere la disposizione futura di un oggetto in funzione della sua velocità e della distanza attuale.

Capacità di ricevere ed interpretare le informazione che giungono alle nostre orecchie attraverso le onde di frequenza udibili trasmesse per via aerea o da altri mezzi (ricezione di informazioni, trasmissione di informazioni, sviluppo di informazioni).
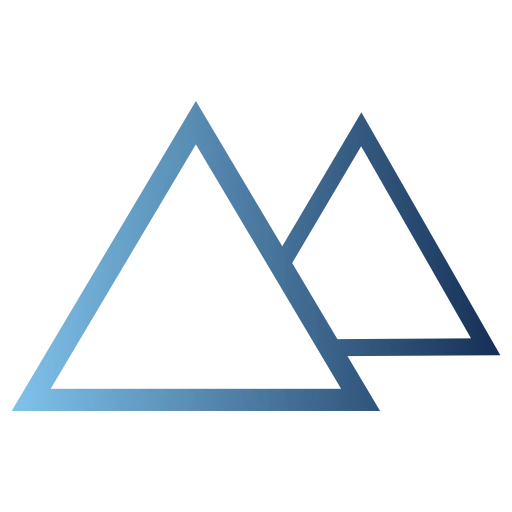
Capacità di identificare gli stimoli che abbiamo percepito anteriormente e riconoscere gli elementi nuovi (situazioni, oggetti, figure, ecc…). Quest’abilità ci permette di recuperare le informazioni immagazzinate nella memoria e confrontarle con le informazioni che ci si presentano davanti.

Velocità con cui una persona capta e reagisce alle informazioni ricevute, che sia per mezzo visivo (lettere e numeri), uditivo (linguaggio) o movimento. Tempo che si impiega dal momento in cui si riceve lo stimolo a quando si emette una risposta.
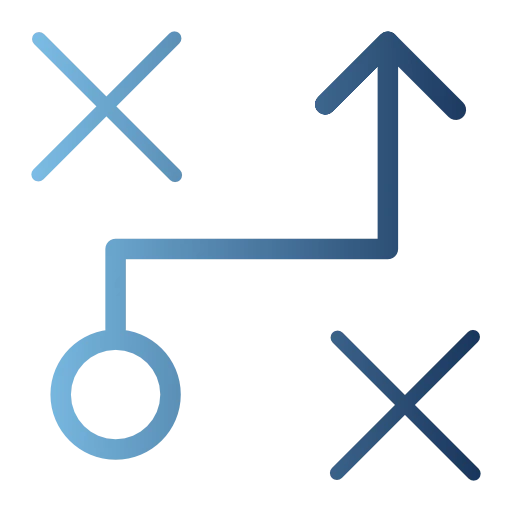
Capacità di anticipare mentalmente la maniera corretta di eseguire un’attività o di raggiungere un obbiettivo. Processo mentale che ci permette di selezionare le azioni necessarie per raggiungere una meta, decidere l’ordine appropriato, assegnare a ciascun’attività le risorse cognitive necessarie e stabilire il piano d’azione adatto.
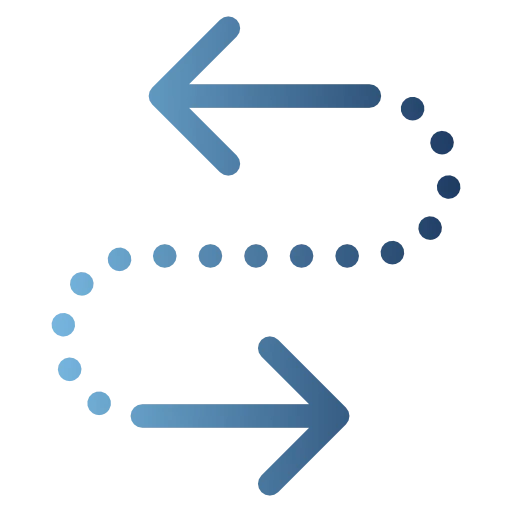
Capacità che possiede il nostro cervello di adattare la nostra condotta e il nostro pensiero a situazioni nuove, mutevoli o inaspettate. Abilità di rendersi conto che ciò che stiamo facendo non funziona, o ha smesso di funzionare, riadattare il nostro comportamento, pensiero o opinioni per adeguarci all’ambiente e alle nuove situazioni.

Abilità che ci permette di realizzare attività nelle quali utilizziamo simultaneamente occhi e mani. Capacità di integrare contemporaneamente le informazioni che arrivano ai nostri occhi (percezione visiva dello spazio) per guidare il movimento delle nostre mani.

Capacità di rilevare, elaborare e rispondere ad uno stimolo. Quest’abilità si identifica nell’avere buoni riflessi, poiché si riferisce al tempo che passa dal momento in cui percepiamo qualcosa fino a quando non diamo una risposta di conseguenza.
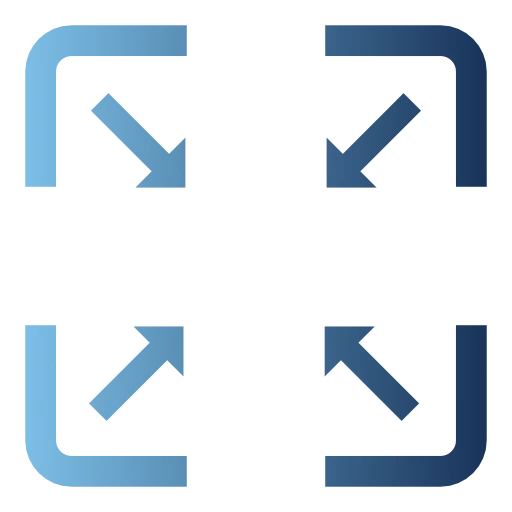
Capacità che possiede il nostro cervello di focalizzare la nostra attenzione su uno stimolo obbiettivo, indipendentemente dalla durata di tale fissazione. Questo tipo di attenzione è quella che ci permette di rilevare rapidamente uno stimolo rilevante.

Capacità del cervello di assistere a diversi stimoli o attività contemporaneamente, rispondendo alle domande dell’ambiente. Permette di elaborare diverse fonti di informazioni ed eseguire più attività simultaneamente.

Capacità di inibire o controllare le risposte impulsive (o automatiche), e generare risposte mediate dall’attenzione e il ragionamento. Quest’abilità mette freno al comportamento e arresta le reazioni automatiche inappropriate, sostituendole con risposte ragionate e più adatte alla situazione.
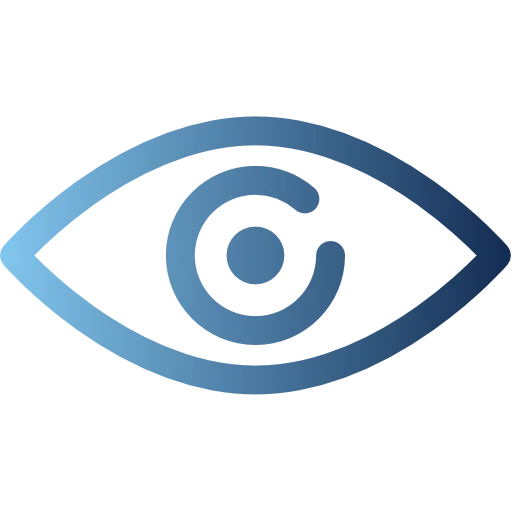
Include i punti del campo visivo non centrali. La “visione periferica lontana” riguarda le aree agli estremi del campo visivo, la “visione medio-periferica” le porzioni intermedie, e la “visione periferica vicina” o “para-centrale” le zone adiacenti al centro dello sguardo.

Capacità di controllare la nostra condotta e assicurarci che compia il piano d’azione prestabilito. Nel caso in cui si verificassero deviazioni, errori o si producesse un cambio di circostanza, il monitoraggio ci premetterebbe di prendere coscienza e di correggere la nostra condotta.
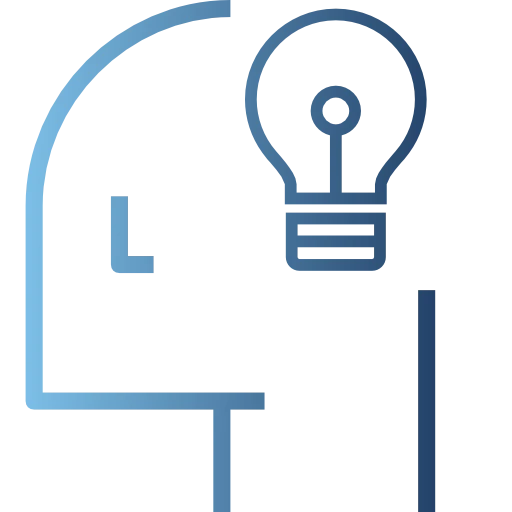
L’intelligenza emotiva è un aspetto dell’intelligenza legato alla capacità di riconoscere, utilizzare, comprendere e gestire in modo consapevole le proprie ed altrui emozioni.
La validità scientifica del Metodo LBT© si fonda su una solida base teorica e pratica, supportata da numerose ricerche nel campo delle neuroscienze, della psicologia cognitiva e delle scienze dell’educazione. Studi recenti hanno dimostrato che l’uso della realtà virtuale e aumentata, della robotica e dell’intelligenza artificiale può significativamente migliorare le funzioni cognitive, la memoria di lavoro e le abilità esecutive degli individui (Smith et al., 2018; Johnson et al., 2020).
L’efficacia del training cognitivo basato sulla plasticità cerebrale è stata ampiamente documentata, evidenziando come l’intervento strutturato possa portare a miglioramenti sostanziali nelle capacità cognitive e nel benessere emotivo (Karbach & Verhaeghen, 2014). Inoltre, l’integrazione di tecnologie avanzate nei programmi educativi e di formazione ha mostrato di promuovere un apprendimento più profondo e duraturo, favorendo l’engagement e la motivazione degli utenti (Dede, 2014).
Le tecnologie impiegate nel Metodo LBT©, come la realtà virtuale, hanno dimostrato di essere strumenti efficaci per la creazione di ambienti di apprendimento immersivi che possono simulare situazioni reali e complessi scenari di problem solving, permettendo agli utenti di acquisire e applicare nuove conoscenze e competenze in modo più efficiente (Slater & Sanchez-Vives, 2016). Allo stesso modo, l’uso di algoritmi di intelligenza artificiale per la personalizzazione dei percorsi formativi consente di adattare continuamente l’apprendimento alle esigenze specifiche degli individui, massimizzando così i risultati (Woolf, 2010).
Il Metodo LBT© è supportato da una vasta gamma di evidenze scientifiche che ne attestano l’efficacia nel migliorare le capacità cognitive, promuovere il benessere emotivo e fisico e favorire un apprendimento personalizzato e coinvolgente. Questo approccio integrato, basato su principi solidi di neuroscienze e psicologia cognitiva, rappresenta un avanzamento significativo nel campo della formazione e del benessere umano.
Le strategie di test adottate per il Metodo LBT© includono:
I test effettuati sul Metodo LBT© hanno evidenziato:
Il Metodo LBT© può essere applicato in diversi contesti, tra cui:
I principali vantaggi del Metodo LBT© rispetto alle tecnologie esistenti includono:
Il Metodo LBT© include una serie di modalità di approfondimento, ciascuna progettata per sviluppare specifiche competenze cognitive, emotive e sociali. Nello specifico, il Metodo LBT© include:
Prevenzione del Declino Cognitivo
Utilizzo di Tecnologie Avanzate
Miglioramento delle Funzioni Cognitive
Promozione del Benessere Olistico
Sviluppo di Modelli Progettuali Replicabili
Ricerca e Raccolta Dati
Adozione delle Nuove Tecnologie
Benessere Fisico ed Emotivo Migliorato
Implementazione di Laboratori Indipendenti
Raccolta e Analisi dei Dati
Coinvolgimento e Supporto della Comunità